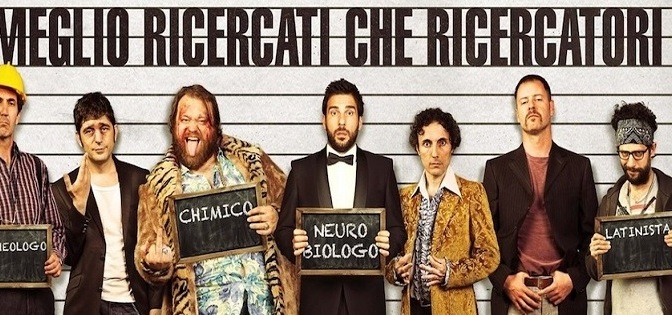Le polemiche sulla ricerca in Italia sono tutte uguali. Perchè non si riesce ad affrontare seriamente il tema della gestione della ricerca? Nell’accademia italiana esiste davvero un dibattito sulla meritocrazia?
Sono bastate poche righe scritte su Facebook da una scienziata Italiana esule in Olanda per trasformare la propaganda social del ministro Giannini in un epic fail. Roberta D’Alessandro ha ragione ed è stata efficace. Su facebook ha praticamente fatto i nomi di chi le ha rubato il posto. Ma c’è da scommettere che una volta spenti i riflettori dei media, cioè fra un paio di giorni, il discorso sulla meritocrazia nelle università italiane tornerà in ghiacciaia.
Perchè non si riesce ad affrontare seriamente il tema della gestione della ricerca, al di là della polemica estemporanea o del piagnisteo per la mancanza di fondi? I soliti sospetti, cioè i media e la politica, hanno un pò di colpa. Le responsabilità di un dibattito pubblico carente sono sempre condivise. Ma siamo sicuri che nell’accademia italiana esista davvero una riflessione sulla meritocrazia? Me ne occupo da tempo, e queste sono le mie conclusioni finora:
-
Di meritocrazia (vera) l’accademia non parla quasi mai.
Gli appelli che arrivano dal mondo accademico italiano – l’ultimo gira online ed è uscito pochi giorni fa (di nuovo) su Nature – denunciano quasi sempre la scarsità dei finanziamenti pubblici e qualche volta protestanto contro l’ennesima riforma piovuta dall’alto. Difficile leggere un appello – o una proposta che non arrivi dai piani superiori dei ministeri- per liberarsi da cattedre inutili e produttive, migliorare o abolire i concorsi, legare i finanziamenti ai risultati e far posto davvero ai più meritevoli. Come se questi temi fossero secondari nel dibattito sulla ricerca (notizia: non lo sono) o rappresentassero un problema della politica e non dell’accademia.
Un’altra causa che di recente ha convinto i professori italiani a salire sulle barricate è una rivendicazione salariale. Per protesta contro il blocco degli scatti di anzianità, 300 di loro rifiutano di sottoporsi alla valutazione Anvur, che per quanto opinabile è l’unica parvenza di valutazione meritocratica della ricerca italiana. Al di là delle idee personali sull’opportunità degli scatti automatici (io li ritengo devastanti, l’antitesi della meritocrazia), siamo sicuri che nelle nostre università non ci sia qualcosa di più urgente e giusto per cui battersi?
Insomma, come in altri campi, anche nella ricerca si parla spesso di merito, ma quasi sempre come una questione NIMBY che riguarda astrattamente gli altri. Magari mi sbaglio e le nostre facoltà abbondano di professori che fra loro discutono animatamente su come far posto ai più meritevoli. Se per loro è davvero una priorità e hanno un piano in testa, sarebbe meglio che lo facessero sapere.
2. La retorica guerresca non si adatta alla ricerca (scienziati, dovreste saperlo!)
Nessuno nega che la carenza di fondi sia un problema serio. Ma chi lavora in università tende a focalizzarsi solo sul tema dei finanziamenti, mettendo in secondo piano i difetti interni al sistema e trattando con sufficienza le critiche che arrivano da fuori.
La resistenza alla critica si concretizza spesso con il ricorso continuo all’emergenza e alle teorie del complotto contro la ricerca libera. Alcuni messaggi contro i tagli finanziari alla ricerca sembrano arrivare da una zona di guerra invece che dagli augusti corridoi degli atenei: “L’università/la libertà della ricerca sono sotto attacco! Ci vogliono demolire! Difendiamo la ricerca pubblica!”
La passione è sempre un valore, anche in comunicazione. Ma prima di fomentare l’idea opinabile di un attacco alla ricerca (da parte di chi?) sarebbe più utile concentrarsi sulla minaccia interna che sicuramente pesa sull’attuale sistema, e cioè la carenza di meritocrazia e organizzazione. La retorica degli appelli insiste sull’urgenza e divide la gente in squadre – con noi o contro di noi, strutturato o precario, pubblico o privato, statalista o liberista- con l’effetto di appiattire e polarizzare il dibattito.
3. L’autoreferenzialità fa più danni di ISIS
Perdonerete l’autocitazione che segue, ma serve a capire. Un anno fa scrissi un articolo su Euroscientist partendo dall’ennesimo appello dei ricercatori contro i tagli ai finanziamenti. Il pezzo riportava voci solidali ma anche critiche verso l’accademia italiana, costantemente col cappello in mano alla ricerca di fondi ma incapace di auto-migliorarsi. Si citavano anche le statistiche sui grant ERC vinti dagli italiani all’estero, gli stessi di cui parla D’Alessandro nel suo colpisci-affonda al ministro.
Per questo articolo fui tacciato di disonestà intellettuale e scarsa professionalità e sommerso di commenti provenienti da un gruppo di accademici “militanti” che in soldoni dicevano: l’università italiana funziona benissimo. I giovani bravi scappano perchè ci sono pochi fondi: datecene di più. Chi non è d’accordo vuole distruggere la ricerca pubblica e riempire l’Italia di atenei privati. Stop. A supporto delle loro convinzioni riempirono le bacheche Facebook di dati bibliometrici sulla ottima produttività scientifica delle nostre università. Quei dati sono veri, li conosco bene e li avevo citati nel pezzo ma non bastano a fotografare un sistema di ricerca (l’articolo spiegava anche perchè).
Al di là delle opinioni personali, questo esempio è sintomatico dell’autoreferenzialità in cui si crogiola il nostro mondo accademico, o almeno la parte più visibile e vocale di esso. La tendenza è ignorare le critiche e nei casi peggiori fomentare l’idea di un complotto contro la ricerca pubblica. I concorsi pilotati? Colpa delle regole ministeriali. Il numero di brevetti inesistenti? Colpa dell’industria che non contribuisce. Le fughe all’estero? Colpa dei fondi insufficienti. Il calo degli iscritti? Colpa dei media che non spronano i ragazzi alla carriera scientifica (non ci crederete ma è quello che davvero si sente dire in molte tavole rotonde). E così via con lo scaricabarile (se volete una rassegna di tutti i guai, con relativa giustificazione cercate qui ).
4. I giornalisti non portano l’elmetto
Alla costante autoassoluzione si somma la retorica della trincea. Gli amici accademici a cui chiedo spesso un feedback sui temi della meritocrazia mi danno sempre indicazioni utili, a volte critiche, ma il tono è spesso improntato all’urgenza militante: “Hai ragione, ma ora bisogna pensare ai finanziamenti, poi al resto”. Il senso è sempre quello: “Siamo in guerra. Se scrivi queste cose danneggi la causa.”
In questa guerra immaginaria, il mondo universitario si aspetta appoggio incondizionato dai giornalisti scientifici, specialmente quando si tratta di far girare appelli e comunicati stampa, ma ignora o taccia di qualunquismo quelli che vanno a sbriciare sotto al tavolo e danneggiano la causa. Magari perchè non si adeguano al piagnisteo, o magari perchè ritengono e scrivono che una scoperta presentata come sensazionale non è poi la fine del mondo.
E’ un rapporto con la stampa malsano e poco rispettoso dei ruoli: un giornalista, per quanto appassionato di scienza, non è un megafono degli scienziati. Il tema -che è internazionale ma in Italia assume contorni militanti- emerge spesso nelle discussioni fra giornalisti scientifici, e ogni tanto ne parla anche in questo gruppo Facebook. Non è ironico che bravi ricercatori, gente che si nutre della complessità del mondo e della forza dirompente del pensiero critico, si mettano l’elmetto e chiedano agli altri di fare altrettanto?
5. Ascoltare le critiche, e magari cercarle, è utile (scienziati: anche questo dovreste saperlo!)
Sia chiara una cosa: non sono un maverick rancoroso contro l’establishment accademico italiano. Al contrario, di quel mondo ho fatto parte con passione finché ho deciso di cambiare strada. Con le università ci lavoro e collaboro (pazienza se quello che scrivo farà arrivare qualche incarico in meno). Ho avuto e ho tuttora il privilegio di frequentare ricercatori di valore assoluto che lavorano, scoprono, pubblicano e si guadagnano la pagnotta in Italia, e meriterebbero di più. Insomma, se dovessi basarmi solo sulle tantissime persone fantastiche che conosco, sarei il fan più sfegatato dell’università italiana e dei suoi abitanti. Ma chiunque abbia frequentato il sistema universitario ne conosce anche i lati perversi e appiccicosi, e non si possono ignorare le moli di informazioni e dati oggettivi che tracciano un quadro inquietante del sistema ricerca.
E’ l’amore per la scienza a farmi dire che la ricerca pubblica vera si difende meglio con una critica documentata, anche feroce, che con cento militanti pronti a morire per la causa. Si difende anche ridicolizzando l’ipocrisia di chi con una mano chiede più fondi e con l’altra si chiude gli occhi di fronte alla palese mancanza di meritocrazia nei propri corridoi.
Si può tutelare la ricerca come bene collettivo e proprio per questo confutare l’idea para-sindacale e devastante che i posti fissi a vita, le infornate, la stabilizzazione e gli stessi concorsi siano la strada giusta e risolutiva da percorrere (vogliamo davvero assumere precari e creare altri posti a vita che intaseranno il sistema per decenni?). Vorrei poter gioire all’idea che le facoltà improduttive chiudano per mancanza di fondi senza per questo venire etichettato come membro di un complotto finalizzato a distruggere l’università pubblica.
6. Non c’è bisogno di distruggere l’università pubblica: si sta divorando da sola.
Il vero nemico della ricerca, se c’è, si annida nelle facoltà e si chiama: concorsi pilotati. Si chiama: corruzione. Si chiama: posto fisso a vita. Si chiama: autoreferenzialità. Si chiama: finanziamenti a pioggia (quando c’erano). Si chiama: rettori e decisori pericolosamente vicini alla politica. Si chiama con i tanti nomi che gli amici universitari conoscono meglio di me.
Chi lavora nell’università farebbe bene a togliersi l’elmetto, prendere la scopa e se ce n’è bisogno fare pulizia nei propri atenei. Non si può sempre dare la colpa agli altri.
I ministri, i politici, vanno e vengono. Roberta D’Alessandro e la sua stoccata su Facebook fra tre giorni saranno dimenticati. Solo dal mondo accademico – non da riforme piovute dai ministeri- potrà arrivare un vero cambiamento, se davvero qualcuno lo vuole.