Omeopatia accademica: le bufale le paghi tu
 L’università di Bologna ha capito dove va il futuro dell’agricoltura: nell’ agro-omeopatia. Sì, avete capito bene: omeopatia applicata alle piante. Un amico mi segnala infatti che l’ateneo bolognese vanta un intero laboratorio dedicato all’argomento (il nome del suddetto laboratorio peraltro non lascia dubbi in proposito).
Bologna non è l’unico ateneo a fare gomitino con le pseudoscience. Anche l’università La Sapienza risulta coinvolta, attraverso un suo dipartimento di Chimica, in corsi di formazione su naturopatia e omeopatia. Da mesi attendo invano che il suddetto Ateneo chiarisca i dettagli, anche economici, della vicenda.
L’università di Bologna ha capito dove va il futuro dell’agricoltura: nell’ agro-omeopatia. Sì, avete capito bene: omeopatia applicata alle piante. Un amico mi segnala infatti che l’ateneo bolognese vanta un intero laboratorio dedicato all’argomento (il nome del suddetto laboratorio peraltro non lascia dubbi in proposito).
Bologna non è l’unico ateneo a fare gomitino con le pseudoscience. Anche l’università La Sapienza risulta coinvolta, attraverso un suo dipartimento di Chimica, in corsi di formazione su naturopatia e omeopatia. Da mesi attendo invano che il suddetto Ateneo chiarisca i dettagli, anche economici, della vicenda. Vi ho appena raccontato due casi inquietantissimi di una ricerca pubblica che da una parte inveisce contro le fake news, le fuffe mediatiche e la disinformazione scientifica, e dall’altra le sostiene e finanzia, attingendo peraltro dagli scarsi fondi pubblici. Proprio mentre l’accademia scatena l’ennesima piagnucolante offensiva mediatica per chiedere più denari.
Il fatto che abbia scovato questi due esempi per caso, nel tempo libero e senza neanche cercarli, mi fa pensare che non siano affatto isolati.Quante sono le università e i centri pubblici che finanziano e sostengono le pseudoscienze?Com’è possibile che nelle nostre facoltà ci siano professori, presidi e rettori che vanno in buona fede a parlare contro le pseudoscienze ad un convegno e poi ignorano che magari nei loro Atenei albergano interi laboratori dediti allo studio dell’omeopatia?Sono domande a cui l’accademia dovrebbe rispondere, subito. Perché se chi racconta baggianate pseudoscientifiche lo fa con il timbro di una grande università, oltre che con i nostri soldi, è un problema serio.
Ne va della credibilità degli atenei (anche se questi ultimi non sembrano particolarmente interessati a mantenere una reputazione, con le conseguenze che vediamo quotidianamente).
Ne va della fiducia dei cittadini verso la ricerca: cosa deve pensare il contribuente a cui viene chiesto di finanziare la ricerca pubblica? Con che faccia un rettore può chiedere uno sforzo economico allo stato se non è in grado di garantire che fondi e stipendi verranno spesi in vera scienza e non in matasse di fuffa pseudoscientifica?
Infine, ne va della credibilità di tutti i ricercatori. Tutti. Anche di quelli bravi che sono tanti e che però stanno zitti.
Ma perché, vi chiederete, gli amici che ho dentro le facoltà mi segnalano privatamente certi casi ma non lo fanno mai pubblicamente, neanche nelle loro sedi? Perché l’università italiana piange miseria – di denari e di dignità- ma resta opaca e omertosa come una famiglia mafiosa.I ricercatori e professori universitari pubblicamente e genericamente si lamentano, ma diventano dei conigli se si tratta di fare nomi e cognomi, o di esporre situazioni imbarazzanti.
Il coraggio dello scienziato, la libertà accademica da sempre vessillo delle università pubbliche nei confronti di chi fa ricerca privata si fermano alla porta del proprio laboratorio: di quello che succede intorno non vedo,non sento e soprattutto non parlo.
L’università non cambierà per merito di riforme politiche o di scandali. Cambierà soltanto se i ricercatori seri ed eccellenti, che ripeto sono tanti, si faranno avanti per rifiutare e denunciare pubblicamente gli abusi della pubblica credulità e dei pubblici denari da parte dei loro colleghi, dei loro direttori, dei loro presidi.
L’università dovrà ritornare Università, con la maiuscola. Oppure morire.
Vi ho appena raccontato due casi inquietantissimi di una ricerca pubblica che da una parte inveisce contro le fake news, le fuffe mediatiche e la disinformazione scientifica, e dall’altra le sostiene e finanzia, attingendo peraltro dagli scarsi fondi pubblici. Proprio mentre l’accademia scatena l’ennesima piagnucolante offensiva mediatica per chiedere più denari.
Il fatto che abbia scovato questi due esempi per caso, nel tempo libero e senza neanche cercarli, mi fa pensare che non siano affatto isolati.Quante sono le università e i centri pubblici che finanziano e sostengono le pseudoscienze?Com’è possibile che nelle nostre facoltà ci siano professori, presidi e rettori che vanno in buona fede a parlare contro le pseudoscienze ad un convegno e poi ignorano che magari nei loro Atenei albergano interi laboratori dediti allo studio dell’omeopatia?Sono domande a cui l’accademia dovrebbe rispondere, subito. Perché se chi racconta baggianate pseudoscientifiche lo fa con il timbro di una grande università, oltre che con i nostri soldi, è un problema serio.
Ne va della credibilità degli atenei (anche se questi ultimi non sembrano particolarmente interessati a mantenere una reputazione, con le conseguenze che vediamo quotidianamente).
Ne va della fiducia dei cittadini verso la ricerca: cosa deve pensare il contribuente a cui viene chiesto di finanziare la ricerca pubblica? Con che faccia un rettore può chiedere uno sforzo economico allo stato se non è in grado di garantire che fondi e stipendi verranno spesi in vera scienza e non in matasse di fuffa pseudoscientifica?
Infine, ne va della credibilità di tutti i ricercatori. Tutti. Anche di quelli bravi che sono tanti e che però stanno zitti.
Ma perché, vi chiederete, gli amici che ho dentro le facoltà mi segnalano privatamente certi casi ma non lo fanno mai pubblicamente, neanche nelle loro sedi? Perché l’università italiana piange miseria – di denari e di dignità- ma resta opaca e omertosa come una famiglia mafiosa.I ricercatori e professori universitari pubblicamente e genericamente si lamentano, ma diventano dei conigli se si tratta di fare nomi e cognomi, o di esporre situazioni imbarazzanti.
Il coraggio dello scienziato, la libertà accademica da sempre vessillo delle università pubbliche nei confronti di chi fa ricerca privata si fermano alla porta del proprio laboratorio: di quello che succede intorno non vedo,non sento e soprattutto non parlo.
L’università non cambierà per merito di riforme politiche o di scandali. Cambierà soltanto se i ricercatori seri ed eccellenti, che ripeto sono tanti, si faranno avanti per rifiutare e denunciare pubblicamente gli abusi della pubblica credulità e dei pubblici denari da parte dei loro colleghi, dei loro direttori, dei loro presidi.
L’università dovrà ritornare Università, con la maiuscola. Oppure morire.
Il DNA Incontra Facebook su Report

Quando hanno proposto di intervistarmi, con il mio solito tatto da portuale labronico ho confessato all’autore Giorgio Mottola miei forti dubbi su quello che avevo visto in precedenza su Report a proposito di salute e tecnologie. Mi ha assicurato che questo servizio sarebbe stato diverso e ho apprezzato il suo lavoro davvero molto accurato per documentarsi, ma restavo un pò dubbioso.
Alla fine devo dire che ho trovato il pezzo informativo e relativamente equilibrato, almeno per gli standard a cui quella e altre trasmissioni ci hanno ormai abituati. Si può non essere d’accordo sul taglio vagamente complottista (vedi “multinazionale cattiva che vuole fare affari col tuo DNA vs Stati Buoni che lo vogliono salvaguardare”): io infatti non sono così d’accordo, anche perchè finora sono stati proprio gli stati a spiare i loro cittadini e inoltre la faccenda del business genomico è più articolata e meno opaca di quanto appaia dal pezzo.
E’ però innegabile che la privacy sia una questione centrale per la genomica di consumo ed è giusto parlare di tecnologie genetiche associandole ai loro aspetti positivi ma anche ai rischi. Molti esempi del servizio sono gli stessi del libro Il DNA Incontra FaceB00k non citato nella puntata ma che è stato inserito come nota di approfondimento nel sito.
Infine, la Good News: dopo la messa in onda, il mio parrucchiere ha chiesto asilo politico all’estero e non farà più danni. Sono curioso di avere il vostro parere (sul servizio, non sulla capigliatura).
Potete vedere la puntata in streaming sul sito RAI (fino a domani, credo)
PS: Il pubblico di Twitter ha notato che per l’occasione indossavo il logo di DYAD, una company fittizia e senza scrupoli che clona esseri umani in una serie distopica. Perchè l’ho fatto, mi ha chiesto qualcuno? Perchè mi divertiva l’idea.
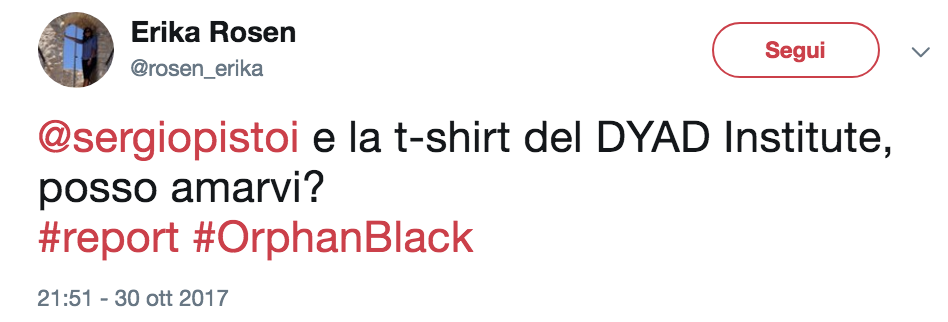

Genetica e divulgazione in tour (Again)
 Per il quarto anno consecutivo sono in tour per le scuole d’Italia insieme al collega Andrea Vico per parlare di DNA, biotecnologie, social network genomici, terapia genica, CRISPR e dintorni. Puoi seguirmi su:
Per il quarto anno consecutivo sono in tour per le scuole d’Italia insieme al collega Andrea Vico per parlare di DNA, biotecnologie, social network genomici, terapia genica, CRISPR e dintorni. Puoi seguirmi su:
www.geniabordo.it
www.facebook.com/geniabordotour
twitter, instagram: @geniabordo
Stanco ma felice.
A presto!

Di tutta l’erba un fascio

L’inchiesta di Firenze potrebbe scoperchiare un pentolone di scandali. Come sopravviverai al popolo indignato che grida “Baroni, Baroni!”?
Differentiate or die di Jack Trout è uno dei pochi libri di marketing che mi hanno ispirato. D’accordo, lo ammetto, è uno dei pochi libri di marketing che ho letto e forse è anche datato.
Comunque sia, Differentiate or Die! è quello che ripeto sempre più disperatamente, da anni, agli amici che lavorano nelle università e che magari si lamentano per gli scarsi finanziamenti o la considerazione sociale sempre meno lusinghiera che l’ambiente accademico riscuote.
Come rispondere al popolo indignato che grida “baroni, baroni!” e far capire che non è tutto così?
Alla luce degli ultimi scandali sulla corruzione nelle università leggo e sento molti bravi scienziati accademici che si pongono sinceramente questa domanda.
La risposta è: differenziandosi. Voglio dire, davvero. Non solo a parole.
Il succo di Differentiate or Die, scrivevo una volta nel mio blog è che se non si vuole morire (commercialmente e comunicativamente ) bisogna fare di tutto per differenziare il proprio marchio e la propria voce da quelle che risultano troppo simili, far risaltare agli occhi del pubblico le proprie caratteristiche distintive e positive e far leva su di esse.
Lamentarsi perchè gli altri fanno di tutta l’erba un fascio non serve.
Specialmente nel mezzo di uno scandalo, i media e l’opinione pubblica fanno sempre di tutta l’erba un fascio. Se in mezzo a quell’erba ci sei anche tu, devi fare capire chiaramente che sei una pianta buona e non gramigna, o verrai trattato come quest’ultima. Differentiate or die.
Differenziarsi non si fa solo quando la merda raggiunge il ventilatore, come succede in questi giorni. Si fa quotidianamente, con le parole e le azioni.
Bada bene, amico accademico: non ti sto facendo un pippone morale, ti sto dando un consiglio tecnico gratuito.
Non basta sapere nel tuo intimo che sei diverso dai cattivi, o che il sistema è marcio e provi a fare del tuo meglio. Bisogna che gli altri lo capiscano. Altrimenti prima o poi sei nei guai.
I cattivi maestri
Quello che proprio non dovresti fare — rimango sempre sul piano tecnico e non morale- è accodarti ai tanti opinion leader accademici che in questi giorni, come sempre, fanno quadrato, minimizzano, usano il solito argomento delle mele marce o peggio ancora si lanciano nell’antico e nobile sport dell’arrampicata sugli specchi.
Il prof. Fabio Sabatini su Strade Online arriva perfino a sostenere che:
Il settore scientifico-disciplinare oggetto delle indagini, “Diritto tributario”, è un piccolo feudo governato da dinamiche che nulla hanno a che fare con la ricerca scientifica e profondamente avulso dal resto dell’università.
(Capito? I feudi accademici sono lì, ben nascosti nelle aule di diritto tributario. Come un tumore in situ. Esci dal firewall e trovi il paradiso. Chiunque abbia notato che anche altrove la trasparenza non sia proprio di casa, per esempio nelle facoltà scientifiche che ho frequentato io e che magari frequentate anche voi, è un ladro bugiardo complottaro e pure spia).
Nulla di nuovo sotto il sole. E’ la classica reazione corporativa, che il pubblico istintivamente riconosce e che potremmo riassumere in: 1) cerco di minimizzare 2) cerco di operare un distinguo 3) aspetto che passi la tempesta e continuo come prima.
Questo schema magari funziona nel breve termine ma produce un danno cronico di immagine che si aggrava nel tempo. Se sei un accademico, devi capire che il tuo status, l’indubbia bravura e onestà tua e/o di molti tuoi colleghi etc.. non ti metterà al riparo dal processo di erosione della fiducia e credibilità che la tua categoria — e quindi tu come individuo, subirete se non fai qualcosa.
Il problema non sono gli scandali, ma quello che succede dopo.
Io penso che l’università italiana sia meglio di quello che tanti immaginano dal di fuori e peggio di quello che raccontano i professori (pubblicamente, perché in privato ne dicono peste e corna).
Ma chiunque sia entrato anche per sbaglio in una facoltà italiana ha ben chiaro che certi metodi baronali non sono il risultato di qualche collega che sbaglia, come sostengono autorevoli commentatori accademici, ma di un sistema anti-meritocratico che da sempre, anche nel mio piccolo blog, mi sforzo di denunciare.
I giudici faranno il loro lavoro, come si dice, ma chiunque conosca l’accademia italiana sa bene che quello che stanno scoprendo a Firenze è assolutamente rappresentativo di ciò che succede quotidianamente in molti atenei: scambi di favori, concorsi e assegnazioni predeterminate, baronie, candidati che vengono dissuasi a presentarsi e invitati ad attendere il loro “turno”, scarsissima trasparenza nella gestione e nei conti.
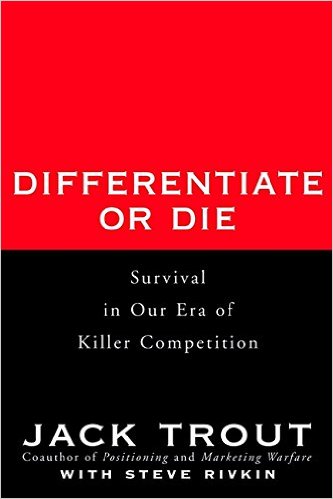
Sono abbastanza d’accordo con chi dice che è quasi sempre il sistema accademico, con le sue regole assurde, che ti fa comportare da barone anche se non vorresti. Mettiamo che tu, come tanti bravissimi ricercatori che conosco, critichi il sistema ma ci convivi, ti adegui per fare comunque qualcosa di buono. Io ti capisco e non ti giudico.
Questo però non cambierà di molto la percezione pubblica della tua categoria e del tuo lavoro. Se fai parte di un sistema sbagliato, lo capisci e lo accetti, è normale che la gente faccia di tutta l’erba un fascio e ti ci metta dentro. E’ perfino giusto, se ci pensi. Differentiate or die.
L’elefante nella stanza

Quello che dovresti fare, se vuoi davvero differenziarti, è isolare chiaramente chi opera certi comportamenti, e non accettare di stare nel mucchio della gramigna.
Temo che per un accademico italiano oggi questa cosa equivalga ad avere tre opzioni: contribuire a cambiare radicalmente il sistema, andarsene, oppure essere percepito come parte di esso e alla lunga, morire con esso. Non ci sono vie di mezzo. Differentiate or die.
Il prestigio del sistema accademico è in caduta libera, e non certo per colpa della stampa o della gente.
Se il letto del fiume non viene ripulito dalla gramigna, se gli argini delle buone pratiche non sono mantenuti, se non si punta sulla trasparenza, ogni notizia negativa è un pezzo di credibilità che se ne va per sempre, finché non rimane niente.
Bisogna ammettere chiaramente, dichiarare, urlare che l’accademia italiana ha un problema enorme di trasparenza. E di controllo di gestione.
Forse addirittura superiore a quello, già grave, di altri settori pubblici.
Ignorare questo elefante nella stanza è un errore fatale. Soprattutto se a farlo sono i ricercatori onesti e produttivi. Che per fortuna sono tanti.
PS: sto aspettando invano da quasi due mesi che l’Università della Sapienza, il più grande ateneo italiano ed europeo, mi fornisca chiarimenti riguardo a fondi (pubblici) di un suo dipartimento di chimica che sarebbero stati usati per finanziare un corso di naturopatia e omeopatia. Alla faccia della trasparenza e dei finanziamenti che scarseggiano. Ed è solo un piccolo esempio.
Tutto quello che un antivax deve sapere.
—
I virus* se ne strabattono il cazzo delle tue opinioni. Sappilo.
* ma anche i batteri
—
(Mi scuso per il turpiloquio ma i virus sono maleducati e io riferisco)
AAA. Qualcuno mi cercava?
Cara Antonella Viola,
eccomi qua. Forse non mi conosci, ma rispondo al tuo annuncio da poco apparso sul Giornale dell’Università di Padova (AAA giornalismo scientifico cercasi) dove lamenti lo stato esecrabile della comunicazione, chiedendoti: “dove sono i giornalisti scientifici”?
Beh, eccone uno. Per esempio.
Mi permetto di darti del tu perché siamo colleghi, o almeno lo siamo stati finché ho lavorato come ricercatore, prima di dedicarmi alla comunicazione scientifica, pur mantenendo felicemente sempre almeno un piede nei laboratori.
Fino al 2010 ho contribuito come consulente alla comunicazione scientifica e al monitoraggio della ricerca Telethon, una delle organizzazioni che ha premiato i tuoi meritevoli progetti scientifici. Un giorno di qualche anno fa ero proprio al V.I.M.M., l’ottimo istituto di ricerca dove lavori, a tenere un workshop di comunicazione per i giovani ricercatori.
Questo per dirti che, anche se facciamo mestieri diversi, non ti scrivo dalla Luna ma da un mondo tutto sommato vicino al tuo, alla tua formazione e sensibilità.
Quello che ti racconterò forse non ti piacerà e non ti troverà d’accordo ma è l’analisi tecnica di un giornalista e comunicatore che è anche ricercatore, da sempre innamorato della scienza e dei suoi complessi risvolti. Una voce indipendente e, credo, sufficientemente temprata nell’agone comunicativo.
Il tuo titolo-annuncio amaramente ironico cela in realtà (per chi non l’ha letto) un commento accurato e sinceramente preoccupato sulla disinformazione scientifica e il “bombardamento“ di articoli e trasmissioni deliranti dove la scienza è maltrattata e comunicata in modo demenziale.
Se fosse solo questo, il tuo sfogo sarebbe un’ incontrovertibile (e condivisibile) cronaca dei fatti. Che tuttavia, lo dico senza ironia, si aggiungerebbe al chilometrico cahier de doléances di accademici che in vent’anni, da quando faccio questo lavoro, mi è capitato di sentire. Perché – e questa è una prima notizia che devi sapere- il bombardamento di cavolate scientifiche non è recente come scrivi e non nasce neanche con Facebook, anzi.
Nei miei ventennali archivi c’è ormai un piccolo esercito di arrabbiatissimi scienziati che, quando i social erano ancora fantascienza, già deplorava la dilagante disinformazione scientifica nei media usando parole che potrebbero essere la fotocopia delle tue, per poi tornare ordinatamente, come è giusto che sia, al proprio lavoro. Una sequela di sfoghi accademici che però hanno sempre lasciato le cose com’erano, anzi forse un po’ peggio. Perché lo sfogo è legittimo, ma (lo dico sempre con grande rispetto) commentare pubblicamente un argomento che non si conosce, che si tratti di scienza, vaccini, calcio o comunicazione, è sempre sbagliato e talvolta dannoso.
Nel tuo articolo ritrovo purtroppo alcuni luoghi comuni che gli scienziati, anche quelli bravi e in buona fede come te, trovano irresistibili ma che risultano infondati e, peggio mi sento, sfociano in uno schema ripetitivo ben noto a chi fa questo mestiere.
Il primo clichè consiste nell’osservare i disastri dei media e concludere che non esistono bravi professionisti nel giornalismo scientifico. Alla domanda retorica (“Dove sono i giornalisti scientifici?” – la risposta implicita è ovviamente: non ci sono!) segue una soluzione apparentemente logica “C’è un disperato bisogno- scrivi- di giornalisti scientifici seri e competenti, adeguatamente formati a livello universitario e post-universitario, ed esorto i mezzi di comunicazione a essere responsabili e non affidare dei temi così difficili e così delicati a persone impreparate”.
Insomma, prima ancora di verificare se davvero ci sia carenza di talenti, si fa già strada la ricetta: formiamo schiere di giornalisti scientifici, naturalmente all’interno dell’Università, e popoliamo con essi il pianeta dell’Informazione!
Cosa c’è che non va, mi dirai?
Per cominciare, c’è che il ragionamento si basa su una premessa sbagliata. Non è vero che non ci siano bravi giornalisti scientifici, anzi.
Chi conosce il mondo della comunicazione scientifica sa bene che in giro ci sono molti professionisti che hanno proprio le caratteristiche di cui parli. Gente preparata, in grado di valutare le fonti e raccontare la notizia scientifica in modo accurato. Gente che conosce e usa Pubmed come dici tu (per inciso, Pubmed è solo uno strumento fra tanti, non la bacchetta magica del buon giornalista scientifico come molti ricercatori pensano). Di questi professionisti ne conosco un bel pò, diciamo abbastanza da soddisfare il fabbisogno italiano dell’informazione scientifica per qualche anno. Molti escono da master di ottimo livello, altri, come me, si sono formati con l’esperienza. Se li cerchi, li trovi. Se non li trovi, sarà mio piacere fartene conoscere qualcuno.
Dove sono? Con le dovute e notevoli eccezioni, sono quasi tutti freelance, tenuti a debita distanza dalle redazioni che contano. Professionisti seri che, piuttosto che guadagnare 30 o 50 euro per un articolo (perché questi sono i compensi medi) fanno comunicazione in altri modi, altrettanto utili e sicuramente più sostenibili. Gente che, lontano dei riflettori, e fra un incarico pagato e l’altro riesce perfino a mettere a disposizione, in rete e spesso pro bono, informazioni preziose che contribuiscono a ribaltare in meglio la percezione pubblica, come nel caso di Stamina. Spesso rimediando all’approccio benintenzionato ma comunicativamente devastante di alcuni scienziati.
Insomma, cara Antonella, capisco la tua frustrazione ma guardati intorno. C’è bisogno di formare nuove schiere di comunicatori scientifici quando neanche si usano quelli che già esistono? E, soprattutto quali atenei hanno le competenze necessarie per farlo? Anche le mie, se non si fosse capito, sono domande retoriche.
Forse non lo sai, ma a parte due o tre rispettabilissimi corsi che tutti nell’ambiente conoscono, la penisola pullula di master di comunicazione scientifica fallimentari, tenuti da scienziati con zero titoli in campo comunicativo. Corsi che aprono come funghi sulla base della presunta mancanza di talenti (ma più spesso per gonfiare l’offerta formativa) e altrettanto rapidamente, quando va bene, chiudono per mancanza di iscritti (perchè alla fine neanche gli studenti sono così fessi da pagare per un master di cartone). Potrei raccontarti una miriade di case-studies divertenti o agghiaccianti, dipende dai punti di vista.
E qui arrivo al terzo luogo comune che ritrovo, almeno in parte nelle tue parole: l’idea ingenua e paternalista secondo cui tutto il problema sta nel passaggio di informazioni dall’esperto al laico, o al giornalista.
“Troppo spesso– scrivi- le nostre parole vengono fraintese o addirittura stravolte, e in questo senso dobbiamo tutti fare uno sforzo per evitare che accada, evitando toni sensazionalistici e pretendendo sempre di leggere gli articoli prima che vengano pubblicati. Ma chiudersi sarebbe un errore: mai come ora è necessario trovare il giusto modo di comunicare la scienza e spiegare il nostro metodo di lavoro, basato su trasparenza, verifica e consenso della comunità scientifica.”
Quello che scrivi è in parte condivisibile, ci mancherebbe, ma rispecchia l’immagine errata che molti scienziati hanno riguardo alla comunicazione. Non voglio tediarti con dettagli tecnici, anche se alcune idee -leggiamo gli articoli prima che vengano pubblicati!- sono irrispettose dei ruoli e comunque impraticabili nel mondo reale, come può spiegarti qualunque bravo comunicatore. Il punto essenziale è che la comunicazione pubblica non è un mondo a compartimenti stagni dove A parla a B (magari a senso unico) ma un ecosistema complesso dove l’informazione circola e prende forma.
Non si risolve tutto con lo scienziato che trova le parole e le immagini giuste per trasmettere il messaggio ad un interlocutore preparato (anche se la scelta dei messaggi, delle parole delle immagini e degli interlocutori è importante), ma esiste una catena alimentare complessa e interdipendente dove le grandi testate, quelle che scrivono quasi sempre le cavolate più seguite, sono spesso i grandi predatori in cima alla piramide.
L’ambiente accademico fatica a concepire che nell’ecosistema dell’informazione non ci sono soltanto scienziati, giornalisti e un generico pubblico da educare. C’è tutto un mondo che, ad esempio, include una serie di figure esperte (ufficio stampa, consulente, coach, stratega) che conoscono i meccanismi e possono fare da cerniera fra scienziati e media. In molti settori questi professionisti sono lo standard. Nella ricerca sono tenuti fuori, vuoi perché i centri accademici non le prevedono o le reclutano male, vuoi perché molti scienziati ritengono (a torto) di non averne bisogno.
Il sistema pubblico di ricerca, che pure sbandiera la necessità di formare e utilizzare buoni comunicatori, non contempla il profilo del comunicatore nell’Abilitazione Scientifica Nazionale e sappiamo bene quanto sia poco disposta a utilizzare, e pagare, competenze esterne che già esistono. Insomma, comunicatori bravi sì, ma not in my backyard. I veri professionisti, quelli che potrebbero fare la differenza suggerendo e implementando una strategia efficace, di solito sono tenuti debitamente alla larga dai laboratori. Al massimo vengono richiesti come moderatori o relatori una tantum per un evento, meglio se gratuito.
Cara Antonella, non voglio metterti in mezzo più di tanto, e non prenderla come una critica personale. Sei una giovane, bravissima e affermata ricercatrice ma è giusto che, dopo esserti pubblicamente espressa su un tema che non ti è così familiare, tu sappia come funzionano davvero le cose.
Devi sapere che il sistema di ricerca italiano, quello che sta alla base dell’ecosistema, quello in cui anche tu lavori e che genera le storie scientifiche di cui poi gli altri parlano, con una mano sbandiera la necessità di una comunicazione responsabile ed efficace e con l’altra svilisce il lavoro dei bravi professionisti. Li tiene fuori dalla porta, ignorandone l’esistenza e preferendo “formare” professionalità fra le mura di casa dove queste competenze però non ci sono neanche fra i docenti. E’ la generazione spontanea delle competenze. Lo sforna-giornalisti automatico per abiogenesi. Un delirio che si avvita su se stesso come le scale di Escher.
Se ti serve un esempio fra tanti, puoi fare qualche chilometro da Padova e andare a Trento, dove la Provincia Autonoma ha finanziato un bando da 1,2 milioni di euro per 4 grant destinati a progetti di “comunicazione della scienza”. 300 mila euro a progetto. Un bel gruzzolo. Riservato però a post-doc a cui non è richiesta, per bando, nessuna competenza comunicativa. Non sto dicendo che siano soldi buttati via o che i progetti non saranno validi (questo si vedrà), ma è davvero il sistema giusto? Accetteresti che un grant di ricerca venisse affidato a uno che fa, per dire, l’assicuratore o l’idraulico, senza alcuna competenza scientifica? Quando succede, il mondo accademico grida giustamente allo scandalo. Chissà perchè, invece, quando si parla di comunicazione tutto fa brodo. In fondo, dai, che ci vuole a comunicare? Qualche mese di formazione e oplà, ecco un nuovo professionista bello e pronto. La generazione spontanea delle competenze nel suo massimo splendore.
Molte Università, e perfino il Ministero della Salute che dovrebbe dare l’esempio, affogano nella deriva di una comunicazione dilettantesca e autoreferenziale senza la minima traccia di strategia. La famigerata terza missione universitaria, a cui spesso ci si dedica senza aver completato con successo la prima e la seconda, è – con le dovute eccezioni – quasi sempre appannaggio di accademici e dei loro collaboratori gratuiti o malpagati, con risultati conseguenti. Progetti europei milionari di divulgazione sono selezionati da comitati di accademici e affidati a ricercatori senza alcuna competenza comunicativa.
Scienziati che si credono comunicatori, quando sono in realtà creatori di contenuti, continuano ad andare in giro come schegge impazzite senza alcun piano organico, confondendo la divulgazione con la persuasione, lasciando poi ai veri comunicatori il compito ingrato di raccattare i cocci di una percezione pubblica a pezzi.
Sia chiaro: il senso di sfiducia che provi verso molti reporter è comprensibile e pure giustificato. L’assenza di un interlocutore preparato e affidabile è un fattore di cui bisogna tenere conto quando si decide se concedere o meno un’intervista. Peccato che –nella mia esperienza- più grande e visibile la testata, più è raro che uno scienziato declini un’intervista o un’apparizione TV, pur sapendo benissimo che dall’altra parte del microfono magari si trova un cialtrone.
Cara Antonella, scrivi che voi scienziati siete stufi, e hai ragione. Ma se ascolti i miei colleghi bravi, e dai un’occhiata a qualche forum specialistico vedrai che anche da queste parti siamo stufi di sentire, da anni, generazioni di scienziati che si lamentano, magari improvvisandosi esperti di comunicazione, senza guardare cosa succede nelle loro stanze.
Capiamoci: se lo sport è quello di dire quanto la comunicazione mediatica faccia schifo, mi iscrivo anche io e potrei vincere il campionato. Per quello che mi riguarda, non scrivo un articolo in italiano da un paio d’anni. Dico solo che il tempo che molti amici ricercatori passano a lamentarsi potrebbe essere meglio impiegato, ad esempio, per dirottare qualche euro per una giornata di formazione seria che non sia la solita e piagnosa tavola rotonda sulla comunicazione. Per riflettere sulle figure che esistono nell’ecosistema e i rispettivi ruoli. Per procurarsi una consulenza seria sulle strategie, un’occasione di coaching, o per finanziare un progetto di comunicazione serio.
Dici giustamente che gli scienziati devono aprirsi alla comunicazione: hai ragione. Questo significa tirarsi su le maniche e ammettere di non avere le competenze. Accettare un contributo esterno, trovando le risorse per includere professionisti capaci nel processo. Siamo stufi di sentire lamentele da parte dei ricercatori e poi, quando offriamo collaborazione professionale, sentirci rispondere le solite menate sulla burocrazia e sulla mancanza di soldi e tempo.
Cara Antonella, se il titolo del tuo post (AAA giornalismo scientifico cercasi) diventasse una vera offerta di lavoro da parte di chi fa scienza, ti assicuro che le cose migliorerebbero assai E’ giusto che tu sappia che esistono tanti bravi professionisti, che sono a disposizione, se solo il sistema di ricerca in cui lavori decidesse di usarli. Te ne posso presentare parecchi, se un giorno come spero ci troveremo davanti ad un buon caffè.
Perché i divulgatori non sono comunicatori (Se pensi di essere un comunicatore, ti conviene leggere).
Al corpulento sergente che lo malmena, Tuco Ramirez, il bandito de “Il buono, il brutto, il cattivo” risponde:
“I tipi grossi come te mi piacciono perché quando cascano fanno tanto rumore!“.
Il sergente, naturalmente, farà un brutta fine.
L’avvertimento di Tuco è utile per tutta la comunicazione ma è nel mondo dei social che diventa oro. Nei social se sei bravo puoi raccogliere un sacco di followers. Se però non li sai gestire, è un attimo che ti si rivoltino contro come droni impazziti. Più sei grande, più il botto è forte se non fai attenzione.
Se ci pensate, esiste un sacco di gente in gamba e in vista che per una frase, magari scritta in buona fede ma senza pensarci troppo, si è trovata nell’occhio del ciclone social. A volte il tonfo è grande e dai social si ripercuote perfino sui canali tradizionali.
Gli scienziati/divulgatori non fanno eccezione. Anzi, direi che sono una categoria ad alto rischio. Alcuni hanno profili molto visibili (e questo è un bene), si danno da fare a trattare temi controversi (bene anche questo), ma non hanno la competenza comunicativa per affrontare le inevitabili crisi e conflitti che un profilo pubblico genera ( e questo, l’avete capito, non è un bene).
Un esempio recente riguarda Roberto Burioni, medico e scrittore noto al grande pubblico per la sua opera di divulgazione sui vaccini.
Si è scatenato il putiferio dopo che il medico, stufo di rispondere ad anti-vax e complottisti assortiti, ha chiuso i commenti sul suo profilo Facebook.
Non è finita: ha motivato la sua decisione con una di quelle frasi che smuovono le acque procellose dei social: “la scienza non è democratica”. Apriti cielo!
Tranquilli, non mi lancerò in discussioni su scienza e democrazia. Mi interessa invece, come sempre, decifrare l’aspetto comunicativo di queste vicende onde evitare, magari anche a voi che leggete, errori potenzialmente fatali.
Questo post prende ispirazione da un interessante scambio che ho avuto con lo stesso Burioni in campo neutro, cioè nella bacheca Facebook della collega Barbara Gallavotti (ringrazio tutti per il lucido e pacato confronto).
Burioni verrà qui presentato suo malgrado come case-study. Il caso è interessante perchè dimostra come basti davvero poco a trovarsi nei guai, anche per un opinion leader preparato e avvezzo al confronto come lui.
Burioni è chiaramente un esperto e un autore-divulgatore. Ha scritto un libro di discreto successo, va in TV ed ha un buon seguito sui social. Volendo è quello che si dice un influencer.
Fin qui tutto bene: ha raggiunto l’obiettivo di far sentire la propria voce, e di riscuotere un certo successo personale.
Allora cosa c’è che non va? C’è che il pubblico, una discreta parte dei media gli attribuisce inopinatamente il ruolo di portavoce della Scienza, della Medicina, della Ragione, di quello che volete. Lui stesso pensa, o forse pensava, che quel ruolo gli calzi a pennello.
Nel vuoto lasciato dalla comunicazione istituzionale finisce che esperti, gli autori/divulgatori, si caricano addosso una figura professionale che non è la loro ed è invece tipica del comunicatore. Questo genera aspettative errate, delusioni, passi falsi e infine, talvolta, il tonfo.
La causa di molti epic fail comunicativi è l’incapacità di distinguere il ruolo dell’ esperto/divulgatore/autore da quello del comunicatore.
Se la questione vi sembra ancora oscura, il motivo è che la confusione imperversa, purtroppo, anche fra molti addetti ai lavori. Cerchiamo di chiarire.
Ho scelto questi termini piuttosto arbitrari: autore/divulgatore e comunicatore. Se non vi piacciono, non fissatevi con le parole e chiamateli come vi pare. Basta che ci capiamo sulle differenze:
Autore/divulgatore è colui che porta la sua voce e il suo messaggio al pubblico. Gli interessa raccontare. La divulgazione è il suo fine.
Comunicatore è il professionista che porta il messaggio di qualcun altro, ad esempio un committente istituzionale. Il comunicatore è uno stratega, con un piano e una competenza specifica. Per il comunicatore la divulgazione non è un fine ma uno strumento. Gli interessa l’effetto finale della comunicazione sulla gente.
Queste due figure possono anche convivere nella stessa persona (è il caso del sottoscritto, che fa alternativamente i due lavori di giornalista-scrittore e consulente per la comunicazione). Si tratta però di ruoli assolutamente distinti.
Vediamo meglio:
- Se scrivo un libro/articolo/documentario sui vaccini, sul DNA, sulla storia del tennis o quello che volete, se vado in giro a fare conferenze per conto mio, sono un autore/divulgatore.
- Come autore/divulgatore (includiamo nella categoria anche il mestiere di giornalista) ho il dovere di raccontare cose vere. Se sono bravo posso anche sperare di cambiare la testa della gente, diventare famoso e vendere un sacco di copie. Ma non ho un piano preciso, non sto dentro ad una strategia. Sono semplicemente uno che ha una storia e la racconta.
Se il ministero Pinco Pallo, l’Università Tizio-Caio o la ditta Acme lanciano una campagna di comunicazione, ecco che entra (o dovrebbe entrare) in gioco un comunicatore professionista che:
- elabora un piano di comunicazione con obiettivi e strategie chiare;
- implementa le azioni previste dal piano;
- valuta il raggiungimento degli obiettivi con metriche misurabili tipo: quante persone che prima non facevano una cosa ora la fanno grazie alla mia campagna? Quanti hanno cambiato percezione? E così via.
Notate le differenze? Eccone alcune:
- L’autore non ha necessariamente un piano strategico e obiettivi chiari e misurabili; il comunicatore deve, o dovrebbe, averli;
- All’autore interessa comunicare un messaggio; al comunicatore interessa l’effetto finale e misurabile della comunicazione sulle abitudini o le percezioni del pubblico;
- L’autore risponde al suo pubblico (se è il caso anche alla legge) di quello che dice; il comunicatore risponde dei risultati della comunicazione rispetto agli obiettivi prefissati, di solito al committente.
- Il bravo comunicatore si vede poco. Lavora in silenzio e nell’ombra, come i personaggi di Clint Eastwood. Ci sono comunicatori sconosciuti ai più, che magari in una delle loro campagne hanno avuto più successo di dieci libri di autori in vista, senza per questo togliere nulla a questi ultimi e alla loro bravura.
 In questa rara immagine: un autore/divulgatore messo a fare il comunicatore
In questa rara immagine: un autore/divulgatore messo a fare il comunicatore
Se prendi un bravo autore/divulgatore e gli fai fare il comunicatore hai in mano una potenziale ricetta per il disastro. Come Clint Eastwood che si fuma il sigaro davanti alla dinamite.
Faresti riparare i freni della macchina al tuo commercialista? Il rischio è evidentente, sono mestieri diversi. Eppure succede, tutti i giorni.
Succede che il pubblico, e anche molti addetti ai lavori, finiscono col rimproverare Burioni per aver chiuso le comunicazioni sulla sua bacheca — un gesto certamente poco inclusivo — dimenticando però che Burioni è un autore/divulgatore, non un comunicatore.
E’ un vizio di molti autori/divulgatori sollevare un tema spinoso e poi, quando magari arriva la bufera di commenti e post, ritirarsi per tornare alle proprie occupazioni. E’ un atteggiamento irritante, specialmente per chi dopo deve raccogliere i cocci di una comunicazione improvvisata, ma è comunque legittimo.
Sono dell’idea infatti che un autore/divulgatore abbia tutto il diritto di andarsene, oppure chiudere i commenti, bannare chi gli pare sulla propria bacheca o sparire dagli schermi nel mezzo di flame che lui stesso ha iniziato. Ma solo finchè non pensa di essere un comunicatore.
Nel mio ruolo di scrittore o nel follow up dei miei articoli, stacco spesso la spina alle teste calde: come autore/divulgatore non ho tempo e voglia di litigare con i fanatici o gli sfaccendati anti-tutto. Taglio e banno silenziosamente molti temibili individui che vedo poi sfogarsi nelle bacheche degli altri.
Come comunicatore, invece, questo non posso farlo.
Reazioni che per un autore sono comprensibili, come urlare la propria rabbia o chiudere le comunicazioni quando il gioco si fa duro, per un comunicatore sono un fallimento professionale.
Se sei un comunicatore, non puoi battere in ritirata, mollare il committente, dimenticare l’obiettivo e rinunciare.
Nella mia carriera da consulente ho lavorato dietro le quinte di campagne anche toste. C’era un periodo in cui ricevevo quotidianamente minacce fisiche dagli animalisti. Ma avevo una strategia, un piano B e un piano C che prevedevano questa evenienza e le relative contromisure. La testa nella sabbia non è mai un’opzione quando fai il comunicatore.
Nel marasma di ruoli finisce che anche i diretti interessati perdano la bussola.
Molti giornalisti scientifici rifiutano giusamente l’idea di essere dei portavoce della ricerca, ma è pieno di altri colleghi che in perfetta buona fede si mettono in trincea, dimenticando il loro vero ruolo di watchdog.
Anche gli scienziati-divulgatori navigano a vista, confondendosi alla grande con i comunicatori.
E’ vero che data l’infima qualità di molte campagne istituzionali (ho già scritto di fallimentari campagne del ministero della salute) è facile per un bravo autore credere di avere fatto centro là dove persino i comunicatori di professione hanno fallito.
Ma è solo un bias cognitivo: non trasforma un autore in un comunicatore, nè un libro, o una pagina Facebook, in uno strumento automatico di conversione. Nel vuoto comunicativo nessuno fa centro.
Soprattutto si fa strada l’ idea tossica, spacciata in giro anche da molti addetti ai lavori, che l’obbiettivo della comunicazione sia quello di coinvolgere e fare parlare la gente.
“Al contrario molti divulgatori di professione, dopo che in otto mesi sono riuscito in quello che loro mancano da dieci anni, ovvero nel fare parlare tutti di vaccini e di scienza, mi dicono che sbaglio […] ”
scrive Burioni in un post (non me voglia, lo uso solo come cavia perchè è rappresentativo di un pensiero frequente).
Come autore, Burioni ha ottime e invidiabili ragioni di essere fiero. Ma dalle sue parole, e non gliene faccio una colpa, traspare il meme tossico di cui sopra: alla fine sono meglio dei comunicatori perchè ho fatto parlare tutti di vaccini!
Lo riscrivo grande così si vede da lontano:
Chi fa una campagna di comunicazione, vuole raggiungere gli obiettivi concreti di percezione e/o azione. Il fine non è far discutere la gente.
Quanti erano gli indecisi e contrari prima e dopo la campagna? Quanti andranno a vaccinarsi prima e dopo? Questo è il tipo di risposte che cerca il comunicatore. Obiettivi, piano, strategia, azioni, verifica. Analisi SWOT. Quello ci vuole. Far parlare tutti non è fare comunicazione.
Nathaniel Mellors, hippy dialectics 2011 — matt’s gallery london monitor rome and stigter van doesburg amsterdam
Le metriche e l’idea che piattaforma non significa risultato sono un altro grande capitolo che differenzia il lavoro del comunicatore da quello del divulgatore/autore.
Da autore/divulgatore, sogno di avere più lettori e follower possibili.
Da comunicatore mi interessa di più il rappporto fra segnale e rumore.
Significa che il numero grezzo di contatti, specialmente sui social, è una metrica che ormai fa sorridere molti professionisti.
Bisogna infatti vedere la loro qualità e tipologia. E non è forse un caso se a scatenare il caso Burioni è stata la sua reazione di fronte ad una mole di commenti che considerava di bassa lega, tanto da indurlo a chiuderli del tutto. Potremmo dire che è un problema di segnale/rumore proveniente dal pubblico.
Sia chiaro, il numero di persone che ti seguono è un dato fondamentale anche per un comunicatore perchè indica l’esistenza di una forte piattaforma. Ma non dice nulla sull’effetto della comunicazione.
I libri sui temi controversi, ad esempio, vengono quasi sempre acquistati da chi ha una posizione simile all’autore.
Avere milioni di lettori o fans che già le pensavano tutti come te è un ottimo risultato per lo autore/divulgatore, ma è un fiasco per un comunicatore.
Non sto suggerendo che gli esperti o gli scienziati/divulgatori debbano rinunciare a cambiare la testa del pubblico, sottrarsi al confronto , chiudere Facebook e darsi alla macchia. Tutt’altro: il loro contributo è fondamentale nell’ecosistema della comunicazione.
Chi si pone obiettivi di conversione, però, deve pensare, appunto, di essere parte di un sistema che include altre figure che non sono sostituibili, e con le quali è opportuno collaborare.
E’ un passo difficile, specialmente quando il pubblico cresce e ti senti invincibile come il sergente di Sergio Leone. Ho fatto parlare Tuco per scherzare, nessuno se la prenda. Ho sempre augurato il meglio a tutti e specialmente ai bravi scienziati.
Le cronache, però, parlano chiaro: fare il tonfo è un attimo.
Mentre con un approccio più strategico alla comunicazione si possono evitare molti guai e raggiungere grandi risultati.
Geni a Bordo: di nuovo in tour
 Dal 5 ottobre sono di nuovo in giro per le scuole d’Italia con il tour Geni a Bordo Il titolo che abbiamo scelto per questa edizione è Biotech Future.
Dal 5 ottobre sono di nuovo in giro per le scuole d’Italia con il tour Geni a Bordo Il titolo che abbiamo scelto per questa edizione è Biotech Future.

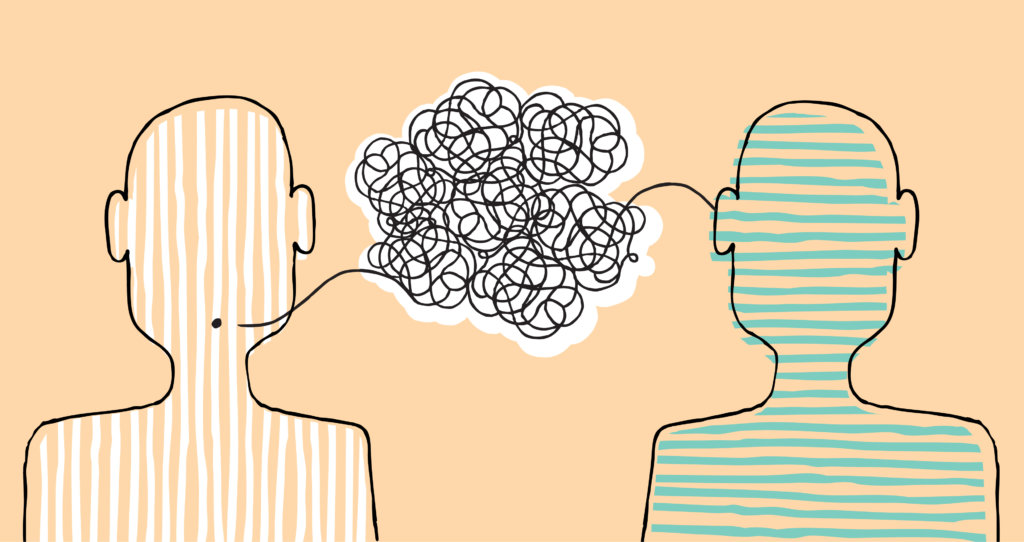

 In questa rara immagine: un autore/divulgatore messo a fare il comunicatore
In questa rara immagine: un autore/divulgatore messo a fare il comunicatore