La mosca cieca del peer review
E´ pronto il piano della Regione che rivoluzionerà il sistema di assegnazione dei fondi per la ricerca scientifica biomedica. [i fondi] verranno assegnati con un sistema “all´americana”, in cui, tra l´altro, il nome dei candidati resterà sconosciuto fino all´ultimo […] (Repubblica 19/09/2008)Come tutti i toscani, sono felice di vivere in Toscana. Non è solo una regione ricca di eventi straordinari, come la Sagra della Nana e il raduno dei Landini Testa Calda dell’ Anonima Peneto Trattori. Dati alla mano, la Toscana è anche un esempio innegabile, nel panorama italiano, di gestione virtuosa della Sanità pubblica.E’ per questo che ho sofferto più del normale leggendo in questo articolo di Repubblica del piano “rivoluzionario” lanciato dall’assessore alla Sanità della mia regione, Enrico Rossi, per il finanziamento della ricerca scientifica. La Tristezza si è poi seduta accanto a me quando, sullo stesso giornale, l’assessore regionale dichiara di ispirasi, per questa “rivoluzione” al modello americano.
Diciamolo subito: il piano “rivoluzionario” della Regione Toscana, non solo non è così rivoluzionario, ma è anche poco sensato agli occhi di chi conosce come funziona l’assegnazione seria dei fondi. Per finire, non c’entra un tubo con il cosiddetto sistema “all’americana”, citato da Rossi.Tralasciando molti dettagli, il problema principale sta nella già citata frase: “il nome dei candidati resterà sconosciuto fino all´ultimo“. Questo peer review “alla cieca” si può definire ottimisticamente come un’ingenuità o, più realisticamente, come una boiata pazzesca.© Sergio Pistoi 2008
Quattordici
 Quattordici è il numero di domande su scienza e ricerca alle quali, puntualmente ed in modo esauriente, hanno risposto i candidati alla presidenza USA Barack Obama e John McCain, chiarendo i loro rispettivi programmi su questi temi.
Quattordici è il numero di domande su scienza e ricerca alle quali, puntualmente ed in modo esauriente, hanno risposto i candidati alla presidenza USA Barack Obama e John McCain, chiarendo i loro rispettivi programmi su questi temi.
A porre le questioni è stato Science Debate 2008, un movimento grassroot (cioè nato dal basso) che raggruppa oggi alcune fra le più grandi associazioni che si occupano di ricerca negli States. La prima domanda dà l’idea del tono, poco retorico e molto realistico del dibattito:
“Science and technology have been responsible for half of the growth of the American economy since WWII. But several recent reports question America’s continued leadership in these vital areas. What policies will you support to ensure that America remains the world leader in innovation?”
Facciamo un piccolo confronto. Vi ricordate quanti punti del programma elettorale dei due principali schieramenti nelle scorse elezioni italiane avevano la scienza come argomento centrale?
Ve lo dico io: Zero.
E non è tutto. Qualcuno ricorderà anche che la rivista Le Scienze, forse pensando di essere in America, provò ad aprire il dibattito ponendo qualche domanda ai due candidati, con lo stesso risultato di cui sopra.
Tutta colpa dei politici di casa nostra, refrattari a tutto ciò che riguarda scienza e ricerca? Non proprio.
Se è vero che i politici si interessano ai temi che (secondo le loro analisi ) toccano più da vicino i loro elettori, la colpa del disinteresse verso la ricerca non può essere soltanto loro.
Un altro confronto è illuminante a tal proposito : Science Debate 2008 (da cui sono scaturite le domande) è nata dall’iniziativa di un pugno di intellettuali, ma si è presto allargata fino ad includere le più grandi società e associazioni scientifiche del Paese.
Si tratta di un’iniziativa strutturata, con un’agenda e un programma precisi, che include istituzioni scientifiche di grande prestigio e peso. In altre parole, Science Debate 2008 rappresenta un gruppo di pressione efficace. Difficile – anche per il politico più disinteressato alla scienza- non rispondere ad una sollecitazione di tale portata.
Da noi le iniziative di sensibilizzazione verso i politici, anche quando arrivano da eminenti scienziati, si limitano a qualche lagnosa lettera aperta sui giornali, o alle ancora più patetiche catene di Sant’Antonio che girano su internet, raccogliendo le firme dei soliti noti- e di tanti ignoti. Il gruppo 2003 è forse, in questo campo, l’unica “grassroot” italiana organizzata con una parvenza di agenda, ma a cinque anni dalla nascita rimane un’associazione di individui (per quanto alcuni di essi siano emeriti e famosi) che non include alcuna istituzione scientifica ed è ben lontano dall’essere un gruppo di pressione.
Lamentele, piagnistei e lettere aperte hanno certamente un effetto catartico. Fanno bene a chi le scrive e fanno indignare per dieci minuti chi le legge e, magari, firma. E’ bene chiarire che questi strumenti, a parte ciò, non servono a nulla. La comunità scientifica dovrebbe invece fare fronte comune e costruire un gruppo di pressione efficace e organizzato, sull’esempio di quelli d’oltre oceano. Solo così si può sperare che la ricerca salga di qualche posizione nell’agenda dei politici.
© Sergio Pistoi 2008
Il buco nero dell’informazione
“Ogni tanto mi sento come uno di quegli schiavi che costruivano le piramidi. Almeno loro dovevano studiare di meno.”
Me lo disse il mio vecchio amico Saverio, forse preso in un raro momento di sconforto. Sono passati cinque anni, forse anche più da quando parlavo con lui in un laboratorio di Frascati. Saverio è un fisico, una delle migliaia di persone, sparse in tutto il mondo, che in questi lunghi anni hanno lavorato alla costruzione dell’LHC, il Large Hadron Collider, l’esperimento che partirà finalmente il 10 Settembre prossimo. Saverio mi spiegò il compito della sua equipe: produrre e verificare l’allineamento perfetto di sottilissimi fili indispensabili ad un pezzo di uno dei rivelatori. Era un lavoro di una precisione certosina, per il quale i ricercatori avevano sviluppato e costruito macchine apposite, computer e software che forse un giorno avrebbero avuto ricadute anche in altri campi. E tutto per costruire un piccolo pezzo del puzzle che avrebbe preso forma a Ginevra. Mi trovavo in uno di quei frangenti in cui pensi che il tuo lavoro, in confronto, non è poi così duro. Quando, recentemente, è venuta fuori la bufala mediatica del buco nero, (una storia creata ad arte da un oscuro biochimico tedesco in cerca di notorietà secondo cui l’esperimento del LHC rischierebbe di creare un buco nero in grado di inghiottire la Terra) ho pensato alle risate un pò amare dei tanti che come Saverio hanno dedicato una parte importante della loro carriera, e della loro vita, a metter in piedi l’ LHC.
La rockstar e la meccanica quantistica
Devo all’amico Ettore Perozzi la segnalazione di questa vera chicca-nerd per gli amanti di musica e scienza. Gli Eels sono una band ormai quasi mitica (nota ai più anche perchè alcuni brani sono stati entrati in colonne sonore di successo,come quella di American Beauty o Shrek). In realtà gli Eels sono una one-man band, il man in questione essendo l’enigmatico e originale musicista americano Mark Oliver Everett.
Agli appassionati di fisica che leggono il forum questo nome avrà fatto già suonare un campanello nella testa. Non è un omonimia, nè un nome d’arte: Mark Oliver non è nientedimeno che il figlio di Hugh Everett III, genio della fisica e padre della teoria degli universi paralleli. Lo scienziato morì precocemente nel 1982, quando Mark Oliver era poco più che adolescente. In un recente e bellissimo documentario prodotto dalla BBC “Parallel Worlds, Parallel Lives” Mark Oliver racconta la riscoperta, da parte della rockstar, del padre (con cui , pur vivendo nella stessa casa, non aveva praticamente mai parlato) e del suo lavoro scientifico. Non è solo un fantastica storia personale, sottolineata da ottime musiche, ma un piccolo-grande prodotto di divulgazione scientifica, che fa uso tra l’altro di geniali animazioni.
Il film è passato sui piccoli schermi degli UK e, a giugno di quest’anno, negli USA, ma non so se è programmata prima o poi una versione italiana. Intanto si può vedere – per fortuna- su you tube. Per ora soltanto in inglese senza sottotitoli. Vale comunque la pena di vederlo e seguirlo tutto, (consiglio la modalità in alta risoluzione) alla bisogna facendosi aiutare a qualche amico anglofono.
Parallel Worlds, Parallel Lives, parte 1
Parallel Worlds, Parallel Lives, parte 2
Parallel Worlds, Parallel Lives, parte 3
Parallel Worlds, Parallel Lives, parte 4
Parallel Worlds, Parallel Lives, parte 5
Parallel Worlds, Parallel Lives, parte 6
Segue playlist di brani degli Eels, giusto per dare un’idea.
La perversione dei Nobel
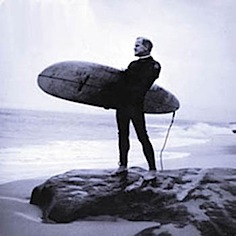 Tempo fa avevo parlato della Sindrome del Nobel, quello strano e pernicioso fenomeno legato al conferimento del prestigioso premio, che a volte trasforma valentissimi e prudenti scienziati in tuttologi a cui tutti danno ascolto e credito, anche quando le loro esternazioni rasentano il ridicolo. In sintesi, la questione era: cosa fare per evitare che il premio Nobel crei dei mostri?
Tempo fa avevo parlato della Sindrome del Nobel, quello strano e pernicioso fenomeno legato al conferimento del prestigioso premio, che a volte trasforma valentissimi e prudenti scienziati in tuttologi a cui tutti danno ascolto e credito, anche quando le loro esternazioni rasentano il ridicolo. In sintesi, la questione era: cosa fare per evitare che il premio Nobel crei dei mostri?
La mia visione vagamente inconoclasta riguardo al Nobel si è rafforzata di recente, dopo che ho assistito, a Torino, dove ero di passaggio ad una delle note performace del Nobel per la chimica Kary Mullis. Premiato come inventore della tecnica rivoluzionaria della PCR (ma la paternità dell’invenzione è sempre stata controversa), Mullis è generalmente catalogato dai media, a seconda dei casi, come scienziato “controverso” “anticonformista”, “eterodosso”. Tutti aggettivi che sembrano nati per suscitare l’interesse più o meno morboso del pubblico. La sala del museo di Scienze Naturali era infatti abbastanza affollata, nonostante l’ora serale e il prezzo del biglietto di ingresso per l’evento, fissato a 12 euro.
Il Nobel statunitense non ha deluso le aspettative di chi era venuto per lo spettacolo. Dopo aver liquidato in poche battute il racconto sui suoi contributi scientifici, ha ricordato le sue tre grandi passioni: le donne, il surf e l’LSD. Poi arrivano le vere chicche: vengono letti brani dal libro di Mulllis, dove si racconta di suo incontro mistico-sessuale con una donna appena sbarcata da un viaggio siderale – poi misteriosamente ripartita. A seguire, una storia ancora più divertente di conversazioni notturne con un procione dalla testa fosforescente davanti alla sua porta di casa. Qualcuno della platea sorride. Ma Mullis non scherza.
Un po’ di gelo si crea quando il Nobel decreta che la spiegazione più semplice di tutti questi strani fenomeni è l’esistenza di alieni. Lui stesso, dice, è stato più volte vittima di alien adductions, di rapimenti da parte degli alieni.
Seduto non lontano da me c’è un collega bravo e piuttosto noto, una vecchia volpe torinese del giornalismo scientifico. Con grande professionalità, ascolta senza battere ciglio i deliri lisergici del Nobel. Solo una rapida smorfia tradisce, per un attimo, il suo disappunto. Il resto del pubblico ascolta in religioso silenzio.
Chi conosce Mullis e suoi libri non si sorprende delle sue sparate. E’ piuttosto sconcertante, invece, il silenzio che regna quando arriva il fatidico momento delle domande del pubblico. Possibile che una audience come quella, non proprio digiuna di scienza, si beva tranquillamente la storia dei rapimenti alieni del Nobel?
Possibile. Invece di una doverosa fila di domande stringenti, dal pubblico arrivano solo commenti accondiscenti, con il risultato che Mullis ha addirittura l’occasione di rincarare la sua dose di ragionamenti bislacchi.
Alla fine non reggo più e in una sala praticamente ammutolita mi alzo per fare una domanda al Nobel.
Non ha pensato -chiedo a Mullis- che le sue strane esperienze si spieghino più semplicemente e razionalmente come allucinazioni -peraltro probabili, considerato il suo uso dichiarato e abituale di allucinogeni- invece che come manifestazioni di intelligenze galattiche?
Mullis mi guarda tranquillo mentre il traduttore gli sussura in un orecchio il mio domandone scettico. Con altrettanta tranquillità mi risponde. No, nessun dubbio, non potevano essere allucinazioni. Non è giusto, dice, che ogni volta che qualcuno sperimenta qualcosa di insolito si parli di allucinazioni. I nostri sensi, l’universo, sono molto più complessi della nostra conoscenza razionale. E poi, aggiunge, è molto più bello pensare che ci sia qualcosa che vada al di là delle aride regole della scienza.
Non replico, sperando di aver lanciato il sasso nello stagno. In fondo, qualcuno doveva pur rompere il ghiaccio. Ora il pubblico reagirà. In effetti, quando torno al mio posto, ricevo segni di approvazione da parte dei miei vicini, e commenti tipo: bravo, ben detto. Nessun altro però prende la parola.
Confesso che non mi aspettavo un atteggiamento così passivo da parte del pubblico, visto il luogo e il contesto, che davano all’evento una parvenza di legittimità scientifica. Ma poi ho capito dove la mia previsione sbagliava: non avevo tenuto conto del potere dirompente del Nobel, un titolo di fronte al quale anche lo spirito più critico e razionale rischia di arenarsi. Mi sono reso conto ancor ancora una volta che il rapporto che il pubblico e i media hanno con il Nobel è di sudditanza assoluta, tale da risultare quasi perversa.
Nella storia umana è difficile trovare un titolo più assoluto e irrevocabile del premio Nobel. Quello che di per sé non è altro che un riconoscimento assegnato da una giuria di esperti per un lavoro eccellente, come nel cinema avviene per gli Oscar o il la Palma D’ Oro, negli anni è diventato, anche grazie ad un lungo ed accurato lavoro di marketing, una patente assoluta e perenne di genialità, senza possibilità di revoca. Di fronte ad un premio Nobel non possiamo che sentirci minuscoli e impreparati. Se una cosa l’ha detta un Nobel, un fondo di verità ci dovrà essere.
Mullis da l’impressione di conoscere bene il potere che deriva dal titolo che gli è stato assegnato, e sembra deciso a sfruttarlo fino in fondo. A modo suo, anche lui ha un rapporto piuttosto perverso con il Nobel. Intascando il prezioso titolo, Mullis ha in fondo implicitamente accettato le regole della scienza, basate sull’osservazione, sulla verifica e sulla razionalità delle ipotesi, e si dovrebbe fare carico anche delle responsabilità morali che inevitabilmente accompagnano un riconoscimento del genere. E invece, come un figlio degenere, se ne va in giro a sputare sul metodo scientifico, spacciando banali aneddoti come prove di fenomeni paranormali. Sfrutta i vantaggi di un riconoscimento scientifico importantissimo, ma disconosce i principi della scienza.
L’ Accademia delle Scienze svedese dovrebbe chiedere a Mullis, e ad altri, di restituire il premio Nobel, almeno simbolicamente. Ma non mi risulta che sia previsto alcun modo per rinunciare a questo riconoscimento quasi sacro. Perfino il diritto nobiliare prevede la revoca dei titoli, in casi gravissimi. Un Nobel invece è per sempre, come i diamanti.
Anche di fronte ad un Nobel non dobbiamo perdere il senso della realtà: fuori dal proprio ristretto campo di competenza, l’opinione di un premio Nobel non è necessariamente più autorevole di quella di qualunque persona intelligente e discretamente informata. Per questo dobbiamo smetterla di dare credito incondizionato ai premi Nobel, amanti o meno dell’LSD, quando parlano di cose che non sanno.
Preghiera Darwiniana: Intervista con Michele Luzzatto
 Parlare di “preghiera Darwiniana” sembra un ossimoro, ma solo in apparenza. In realtà, accostare i due termini è meno strano di quanto appaia a prima vista, ci racconta Michele Luzzatto, autore di un bel libro che offre una prospettiva inedita e interessante nell’annosa contrapposizione fra evoluziosmo e creazionismo (scienza e pseudo-scienza) e sulla presunta “empietà” del pensiero di Charles Darwin rispetto ai dogmi della fede. Biologo di formazione, editor per la saggistica scientifica di Einaudi (e non credente), Luzzatto accosta arditamente, ma con cognizione di causa, la figura di Darwin con quella di due personaggi biblici, Giobbe e Giacobbe. La conclusione è che “proprio che si scaglia contro Darwin finisce, paradossalmente, col trovarsi piuttosto distante da Dio, se c’è un Dio”.
Parlare di “preghiera Darwiniana” sembra un ossimoro, ma solo in apparenza. In realtà, accostare i due termini è meno strano di quanto appaia a prima vista, ci racconta Michele Luzzatto, autore di un bel libro che offre una prospettiva inedita e interessante nell’annosa contrapposizione fra evoluziosmo e creazionismo (scienza e pseudo-scienza) e sulla presunta “empietà” del pensiero di Charles Darwin rispetto ai dogmi della fede. Biologo di formazione, editor per la saggistica scientifica di Einaudi (e non credente), Luzzatto accosta arditamente, ma con cognizione di causa, la figura di Darwin con quella di due personaggi biblici, Giobbe e Giacobbe. La conclusione è che “proprio che si scaglia contro Darwin finisce, paradossalmente, col trovarsi piuttosto distante da Dio, se c’è un Dio”.  Ho intervistato l’autore per parlare del libro, di religione e di alcuni aspetti interessanti della vita di Darwin. Ascolta l’intervista:
Ho intervistato l’autore per parlare del libro, di religione e di alcuni aspetti interessanti della vita di Darwin. Ascolta l’intervista: 
Divulgazione scientifica in 3 minuti
Riuscite a raccontare il vostro lavoro in modo spumeggiante e in soli 3 minuti? Se pensate di farcela, siete pronti per partecipare alla seconda edizione del CellSlam, una divertente e interessante iniziativa destinata, sembra, a diventare una tradizione al Meeting Annuale della American Society for Cell Biology (ASCB). Nella stessa occasione di tiene anche il CellDance Festival, di cui ho già parlato in un altro post.Nella loro semplicità, questo tipo di eventi sono probabilmente molto più utili di tante altre (costose) iniziative tese a favorire la divulgazione scientifica, perchè seguono un precetto fondamentaledella comunicazione scientifica: mai prendersi troppo sul serio.Le regole dell CellSlam sono poche ma semplici:
- 3 minuti di tempo
- Nessun audiovisivo (dimenticatevi le slides). Volendo, però, si possono usare strumenti musicali o altre diavolerie
- Obbligo di divertirsi ed essere divertenti
Per darvi un’idea, guardate in questo video i concorrenti dell’anno scorso. Alcuni sono veramente bravi e divertenti.